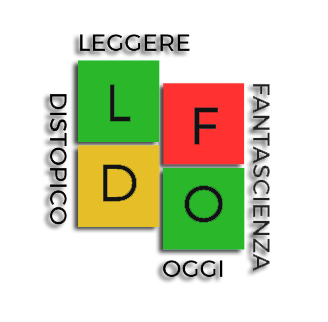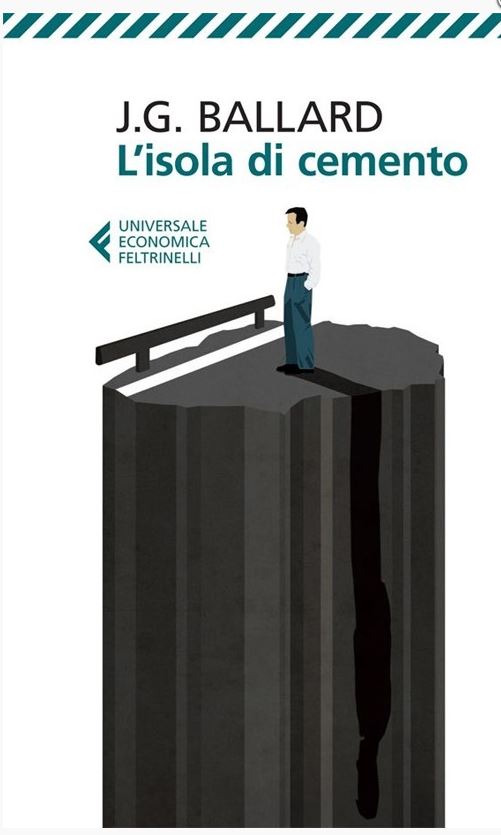
Gli anni ’70 rappresentano nella produzione di James Ballard il passaggio da una narrativa catastrofica all’elaborazione distopica del tema della solitudine nella società contemporanea. Fase inaugurata da Crash (1973), e poi sviluppata ne L’isola di cemento (1974) e poi Il condominio (1975).
TRAMA
I protagonista Robert Maitland vive una vita tipicamente borghese, una moglie, un figlio, un buon lavoro, ma è profondamente insoddisfatto. Un giorno però la sua Jaguar finisce fuori strada, l’auto si distrugge, lui resta ferito, ma soprattutto si trova come imprigionato in una zona nascosta sotto l’autostrada. Impossibilitato a risalire la scarpata per via delle ferite, si trova a vivere come una specie di Robinson Crusoe, bevendo l’acqua del radiatore o la pioggia, in questa sorta di isola, così la chiamerà il protagonista, dove incontra due “indigeni”, un ex acrobata minorato mentale e una ragazza di vita drogata e non meno stramba. Con loro avrà inizio una specie di lotta per la vita, fatta alternativamente di violenza e di aiuto reciproco, di sopraffazione e di tenerezza.
Dapprima il protagonista cerca di andarsene, poi però sembra quasi adattarsi a quella condizione di isolamento e marginalità che lo tiene lontano dalla vita quotidiana percepita, evidentemente, più disumana di quella.
RECENSIONE
Ciò che colpisce il lettore è prima di tutto lo spazio che il protagonista gli descrive: perfetto esempio di non-luogo, cioè uno spazio privo di qualsiasi identità, è l’area di uno spartitraffico, è lo spazio sotto un cavalcavia, uno spazio morto, dove restano tracce di antiche attività, auto abbandonate, reti metalliche, erbe alte, ortiche, qualche rudere. Un mondo abbandonato e dimenticato, apparentemente invivibile. E’ un’isola di cemento, appunto, perfetta rappresentazione della devastazione che la civiltà contemporanea ha compiuto nei confronti della natura. Eppure è proprio in quel ritaglio di mondo che il protagonista espulso da un incidente dalla sua bella vita borghese, si trova a riscoprire un’altra faccia dell’esistenza, quella della sofferenza, della miseria, della marginalità, dell’emarginazione. Una condizione del tutto estranea alla logica e al buon senso, fuori del circuito economico, in cui si vive di avanzi gettati dalla cucina di un fast food.
Ballard anche qui crea un mondo che in realtà altro non è che la proiezione del nostro, o meglio delle angosce contenute nel nostro mondo. Porta così all’estremo la condizione di solitudine dell’individuo contemporanea incapace di vedere ciò che la civiltà, la modernità, il benessere lasciano indietro.
Stefano Zampieri